
I ragazzi che rifiutano l’orale ci stanno comunicando dei messaggi. Una lettura psicologica
Da un punto di vista psicologico, possiamo fare delle riflessioni per rispondere a una domanda: quali elementi possiamo valorizzare nel comportamento di questi studenti?
Condividi su:Rifiutando di sostenere la prova orale dell’Esame di Stato, alcuni studenti e studentesse hanno sollevato questioni significative sul sistema valutativo e le dinamiche normative della scuola italiana. Di certo, poiché parliamo di espressioni di autonomia intellettuale e non di crimini, il loro gesto dovrebbe essere valorizzato mediante una considerazione attenta, senza banalizzazioni. Da un punto di vista psicologico, a riguardo, possiamo fare delle riflessioni per rispondere a una domanda: quali elementi possiamo valorizzare nel comportamento di questi studenti e studentesse?
Una prima risposta si lega alla natura del gesto. Il rifiuto di sostenere la prova orale è un atto comunicativo complesso e, come direbbe Bandura, si basa su una percezione di autoefficacia. Ogni essere umano, nella maggior parte dei casi, mette in pratica ciò che sente di riuscire a fare. Nel caso dell’Esame di Stato questo è facile. Infatti, anche sostenendo una prova in meno, si può raggiungere un voto positivo, che può essere anche buono (fino a 80 su 100). Il rifiuto, pertanto, pone una domanda scomoda ma legittima: quale importanza reale hanno le prove d’esame?
In seconda analisi, si può rispondere considerando la profondità del messaggio. Non si tratta di semplice opportunismo che sfrutta una falla nelle regole, come detto da molti adulti. Studenti e studentesse stanno comunicando un concetto che può essere difficile da comprendere e accettare: le regole hanno un senso se servono per sostenere il benessere collettivo e il rispetto dei diritti umani. Se questo scopo delle regole viene meno, possono (e in alcuni casi devono) essere messe in discussione. Anche la Dichiarazione di Parigi 2025, che vede l’Italia come firmataria, va in questa direzione, sottolineando la necessità di aver cura della salute mentale in ogni politica (inclusa quella scolastica e lavorativa). Rispettare le regole semplicemente perché esistono, senza interrogarsi sulla loro ragionevolezza o funzionalità, ha meno senso (anche se questo viene proposto dal ministro Valditara).
Un’ultima risposta, infine, si collega alla percezione del basso valore del titolo di studio e del rituale dell’esame di maturità, evidenziata dal gesto di questi studenti e studentesse. Si tratta, purtroppo, di un atteggiamento in linea con quello di molti adulti. Non è un caso, infatti, che nell’attuale contesto socio-economico il diploma sia sempre più definito un “pezzo di carta”, svuotato della sua importanza e del suo significato. Una sfida ministeriale e per il mondo della scuola in generale, pertanto, potrebbe consistere nel riconoscere il valore comunicativo di questi gesti. Le reazioni punitive basate su idee preconcette, attuate semplicemente perché si ha il potere di attuarle, andrebbero evitate. L’intelligenza di chi orienta la scuola dovrebbe concentrarsi per risolvere i problemi, non per punire chi li evidenzia.
I messaggi di queste comunicazioni, di fatto, possono essere trasformati in occasioni di miglioramento, coinvolgendo professionisti del settore che hanno competenze scientifiche sulla valutazione e sulla salute mentale. Questa sfida, che richiede maturità istituzionale e apertura al dialogo intergenerazionale, può favorire la crescita collettiva su aspetti importanti: il valore reale delle prove dell’Esame di Stato; lo sviluppo di regole utili per il benessere; la strutturazione di percorsi scolastici che abbiano un impatto positivo per la vita, anziché essere un mero assolvimento burocratico.
Fonte: Blog






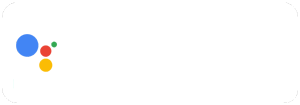
 srl - P.I.06418320724
srl - P.I.06418320724
 srl - P.I.02707140287
srl - P.I.02707140287
 ®
®